

Arrival di Denis Villeneuve si è aggiudicato l’ambito record di 8 nomination agli Oscar per un film di fantascienza, e non per i premi tecnici, che di solito spettano alle pellicole che esplorano l’ignoto. Stavolta è in gara per anche miglior film e miglior regia. Un bel riconoscimento per la nuova ondata di fantascienza matura, esistenzialista, tramite la quale riusciamo entrare in contatto con l’ignoto della nostra mente.
Il ruolo del genere fantascientifico, non solo al cinema, è sempre stato quello di esplorare l’ignoto ed entrare in contatto con lo sconosciuto, il diverso per riuscire a capire qualcosa di più del mistero dell’universo. Molte volte però la solitudine e l’isolamento dentro lo scafandro o dentro l’astronave, portano i protagonisti a entrare in contatto con la parte più ignota di se stessi per scoprire che hanno un universo misterioso dentro e che quello fuori, oltre l’atmosfera terrestre, è anche metafora del proprio cervello.
Arrival ci porta l’ignoto direttamente a domicilio. La linguista Louise Banks (Amy Adams) è stata scelta da una squadra speciale governativa per provare a stabilire un dialogo con gli alieni che sono apparsi con le loro astronavi a forma di guscio nero in dodici luoghi del mondo, senza nessun motivo apparente. Evitando gli spoiler, il film ci mostra un nuovo linguaggio e una nuova concezione del tempo, non lineare ma circolare, proprio come i segni pieni di informazioni con cui comunicano gli alieni.

Un viaggio nel tempo e nella psiche che non può non essere accomunato a Interstellar di Christopher Nolan (2014), in cui per salvare la Terra da morte certa dovuta al cambiamento climatico, l’astronauta Joseph Cooper (Matthew McConaughey) compie un lungo viaggio in solitaria che termina con la negazione stessa del concetto di tempo per come lo conosciamo e della sua individualità, della sua unicità come essere umano che cresce in rapporto con l’ambiente a la famiglia.

La solitudine totale, ineluttabile che prova McConaughey quando si trova all’interno del Buco Nero, metafora spaziale della propria anima e della propria vita, è anche quella che provano i protagonisti di due film recenti. Quella di Matt Damon in The Martian di Ridley Scott (2015), che si trova perso su Marte, oppure quella di Chris Pratt in Passengers di Morten Tyldum (2016), che si risveglia dal sonno criogenico 90 anni prima del previsto e dovrà affrontare un viaggio spaziale che dura una vita umana in completa solitudine. Proprio il terrore del monologo interiore che devono affrontare tutti gli astronauti dei film che abbiamo citato, lo porta a risvegliare una sua compagna di team, interpretata da Jennifer Lawrence, per poter condividere l’isolamento e la lontananza.
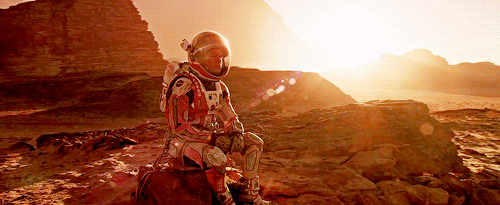
Un alto grado di riflessione sull’identità è presente anche nell’introspettivo Moon di Duncan Jones del 2009, in cui Sam Rockwell interpreta l’unico residente di una base mineraria lunare, che allo scadere dei tre anni di contratto scopre un suo clone in un veicolo abbandonato dopo un incidente sulla superficie lunare. Questa consapevolezza lo porta ad un’autoanalisi estrema e alla convivenza reale con se stesso.

Quello del contatto fisico con se stessi è un espediente utilizzato anche in Another Earth di Mike Cahill del 2011, con Brit Marling (scrittrice e protagonista di The OA), in cui appare all’orizzonte nel cielo un pianeta Terra del tutto simile al nostro, abitato addirittura dalle stesse persone, che però hanno preso strade diverse da quelle della Terra che conosciamo, e che possono addirittura incontrarsi faccia a faccia per un confronto. Un altro modo per toccare con mano il proprio clone.

Quando la fantascienza raggiunge direttamente il nostro pianeta, la trama spinge sull’esistenzialismo, tanto più se riguarda una possibile versione della fine del mondo. Melancholia di Lars Von Trier del 2011, con l’espediente del pianeta che entra in collisione con la Terra, obbliga le protagoniste Kirsten Dunst e Charlotte Gainsbourg a scambiarsi psicologicamente ruoli e personalità, aspettando l’inevitabile.

Ogni trama, al netto della riuscita del film, parla di nuova concezione di tempo, di solitudine e di incontro con se stessi, che è proprio ciò che succede durante una seduta di autoanalisi. Un’esperienza extracorporea che prende come metafora lo sconosciuto, il diverso, l’infinito per sondare gli aspetti più remoti dell’animo umano e le reazioni più estreme che esso possa suscitare. Lo scafandro diventa la gabbia della propria mente, la comunicazione diventa scoperta e contatto, per uscire dalla solitudine che porta alla umanissima depressione. Che poi sia rappresentata da un pianeta che distrugge la Terra o dal brutto rapporto con se stessi, poco importa. Human, proprio come il cartello con cui Amy Adams prova a parlare con gli alieni, e il cerchio si chiude.
